Due ore di lezione con una decina di
dottorandi dell’Università di Macerata. Che esperienza bella e arricchente! Sapere che ci
sono giovani che fanno sul serio… Il mio tema era il percorso storico del concetto di carisma, con un confronto tra il ritratto del
leader carismatico tracciato da Max Weber e quello di un fondatore di un
movimento religioso.
Weber utilizza il concetto biblico di carisma
per descrivere e analizzare un certo tipo di potere che chiama appunto carismatico, gestito da una persona che si
manifesta in particolari momenti di bisogno o di crisi, quando la gestione
ordinaria del potere si mostra incapace di apportare i cambiamenti necessari. Con
modi insoliti, spontanei e creativi, egli è capace di trasformare lo status quo. Rompe con determinati schemi
ormai inadeguati, ed è portatore di nuovi valori e modelli di comportamento. È
animato da ideali propri, distinti dalla quotidianità della vita ordinaria, e
dal desiderio di diffondere il messaggio su cui si regge. Si sente investito da
un compito. È un eletto, un ispirato, a cui è stata affidata una missione. Detiene
qualità straordinarie che lo portano a galvanizzare attorno a sé un gruppo di
seguaci-discepoli che lo riconoscono come leader indiscusso: gli accordano
piena fiducia e obbedienza incondizionata…
Troviamo elementi di continuità e di discontinuità nei
fondatori e nelle fondatrici rispetto al profilo del “capo carismatico” elaborato da
Weber. Ho rilevato soprattutto le discontinuità. Tra le altre la non sempre
evidente presenza di qualità straordinarie. Il più delle volte ci sono, ma il
soggetto non fa leva su di esse; preferisce mettere in luce le proprie
fragilità, inadeguatezze…, così da dare risalto all’azione gratuita di Dio in
lui, che ne diventa strumento. In ciò vi è una continuità con Paolo, al quale spesso essi fanno esplicito
riferimento, citando proprio il testo tratto dalla Lettera sui carismi: «quello
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello
che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello
che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto
per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di
fronte a Dio» (1Cor 1,27-29). Occorre sempre distinguere tra il
dono di Dio – il tesoro, in questo caso il carisma – e il vaso di creta nel
quale esso è contenuto (cf. 2 Cor 4, 7).
Il carisma del fondatore ha inoltre una
dimensione collettiva, che continua anche dopo la sua morte. Ed è questa una
realtà sorprendente. Quando il fondatore muore, si adempie la parabola
evangelica del chicco di grano che deve cadere in terra e morire per portare
frutto. La sua morte è l’inizio di una nuova fecondità. Sembra di sentir riecheggiare le parole
di Gesù: «È bene che io me ne vada, altrimenti non potrà venire a voi lo
Spirito» (cf. Gv 16, 7); «Farete cose
più grandi di me» (cf. Gv 4, 12).
Perché il carisma possa sprigionare tutta la sua creatività è necessario il
dono estremo della vita da parte del fondatore.
Bello il breve ma intenso dialogo con gli studenti,
colpiti soprattutto dalla dimensione sociale dei carismi religiosi, che ho loro tracciato, e dal contributo da essi dato alla storia umana… Interessati (e preoccupati) delle nuove sfide che tecnologia e informatica pongono alla nuova leadership mondiale. Occasione
per parlare insieme del valore dei rapporti personali, della costruzione della
fraternità…

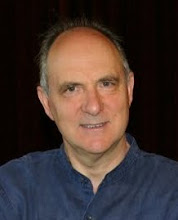
Nessun commento:
Posta un commento