Inizia con un “pianissimo”,
come in uno spartito musicale. Non sai ancora quali temi sta per riservarci e
già pone in attesa, accende il desiderio e promette una sinfonia ricca di
melodie. Durante l’ascolto – in questo caso la lettura –, come in un brano
musicale, avremo l’impressione costante, lungo tutto il libro, di sentire la
voce narrante.
Il genere autobiografico
affascina perché racconta una vicenda dal di dentro, come nessun altro, se non
il protagonista, potrebbe fare. La biografia procede diversamente: segue le
tappe del vissuto con la massima oggettività, con uno sguardo esterno. L’autobiografia
sceglie, elimina, rilegge la trama della vita, la rielabora in maniera
creativa, ne coglie il senso. Non è cronaca, è una rilettura – a distanza di
tempo – del proprio percorso, della propria esperienza. (…) Più che la propria
storia, Gabriella Fallacara sembra narrare la storia di altri, nella quale è
coinvolta non come spettatrice passiva, ma come amica e compagna di un viaggio
che, da familiare, si fa culturale, politico, ecclesiale, sociale, e da Firenze
si allarga a tutta l’Italia, a tutta l’Europa.
È la storia dell’Italia
coinvolta nella Seconda guerra mondiale e della ricostruzione difficile e piena
di speranza del dopoguerra, attraverso gli occhi di una bambina, di
un’adolescente, di una giovane in attesa… In questo modo si possono sentire
veramente la paura, la fame, la pietà… È la storia del Movimento ecumenico,
fatta di persone più che di idee. E quanti nomi vediamo scorrere lungo questo
libro: nomi che lentamente acquistano un volto distinto, che impariamo a
conoscere e ad amare. Una storia fatta di luoghi, di incontri, di attese, di
conquiste, forse di illusioni.
(…) è la storia vista con
gli occhi di Gabriella Fallacara e dunque personalissima e non per questo meno
vera. Anzi, gli eventi noti si colorano di nuova luce e insieme veniamo a
conoscenza di ulteriori particolari inediti, che arricchiscono la narrazione, la
rendono viva, appassionante, colta nel suo momento sorgivo, quasi in presa
diretta, grazie anche alla memoria vivissima dell’autrice e delle numerose note
appuntate negli anni e preziosamente custodite.
Il racconto fa rivivere il
fiorire dei primi focolari in Italia e in Europa. Vediamo la stessa Fallacara a
Parma, Sassari, Grottaferrata, Bruxelles, Siracusa, oltre Firenze,
naturalmente, e numerosi luoghi di Roma, con una disponibilità e libertà di
movimento che denotano una fede grande nell’Ideale che animava quel primo
gruppo. Assistiamo al crescere delle Mariapoli, al diffondersi del Movimento,
alla nascita delle opere editoriali, della cittadella di Loppiano, del Centro
per l’ecumenismo. Soprattutto, prima delle opere, emerge il valore delle
persone. I protagonisti di questa storia sono sorprendentemente numerosi,
uomini e donne con i quali, tra l’altro, la scrittrice ha avuto un rapporto
personale. Ogni persona si staglia con la sua inconfondibile personalità, in un
intreccio costante di legami che mostrano, tra l’altro, la tipicità
“collettiva” del carisma che tutti li lega. (…)
Alcuni profili, a cominciare
dai patriarchi Atenagora e Bartolomeo, si stagliano con tratti marcati, frutto
di una lunga frequentazione; in particolare con Bartolomeo da quando egli
studiava al Pontificio istituto orientale a Roma. Tra tutti, accanto al rilievo
dato a Pasquale Foresi, si stagliano le figure di Chiara Lubich e Igino
Giordani. (…)
Chiara Lubich è la persona
forse più presente lungo tutto il libro. Anche di lei scopriamo mille
particolari che la rendono viva e umanissima. Gabri (possiamo ormai chiamarla
così, familiarmente, come fanno tutti nel Movimento dei Focolari?) l’ha incontrata
quando era ancora una ragazzina, a un pranzo in un ristorante di Firenze. (…)
Una storia “personale
speciale”, quella narrata da Gabriella Fallacara, che si innesta nel percorso
nativo del Movimento dei Focolari, e domanda di essere continuata, senza niente
di nostalgico, con una fiduciosa apertura al futuro, come già lei stessa scriveva
nel 1976: «Il carisma è stato dato a una persona che è stata lavorata per tanto
tempo appositamente e questa persona lo ha comunicato a tanti, e lo comunicherà
a tanti. Quindi ci sarà una continuazione di questo dono, in questo senso: ci
sarà una comunicazione e ci sarà una partecipazione».
Parte della presentazione che Gabri mi ha chiesto di scrivere per il suo libro: "Il coraggio di rischiare".


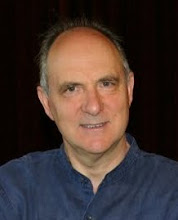
Nessun commento:
Posta un commento