Nell’attesa dell’elezione del nuovo papa provavo a immaginare
quale nome avrebbe preso. Mi sarebbe piaciuto Agostino, perché ho l’impressione
che la Chiesa necessita di una maggiore unità al suo interno, di essere animata
dalla carità e di continuare il cammino sinodale, aperta sul mondo, per
coinvolgere tutti nell’unità e nella carità. Il nuovo papa ha scelto un altro
nome… ma è un agostiniano! L’ha subito dichiarato nel primo saluto dalla Loggia
centrale della Basilica di San Pietro, l’8 maggio 2025: «Sono un figlio di
Sant’Agostino, agostiniano…».
Papa Leone non è soltanto un semplice agostiniano, è stato priore
generale dell’Ordine degli Agostiniani per 12 anni, dal 2001 al 2013. È ben più
di quanto mi sarei aspettato pensando a un papa che si fosse chiamato
“Agostino”!
Sant’Agostino, dopo 16 secoli continua a ispirare, come ha
fatto lungo tutta la storia della Chiesa, a cominciare da san Benedetto, su su,
fino a oggi. Al riguardo ho scritto un articolo per “Nuova Umanità”. Al termine
ho mostrato come sant’Agostino ha ispirato anche Chiara Lubich, la cui
spiritualità, al dire di un grande studioso di sant’Agostino, forse il più
grande, sarebbe “proprio agostiniana”.
Priore generale dell’Ordine agostiniano, padre conciliare,
fondatore dell’Istituto Patristico Augustinianum, p. Agostino Trapé concepì
l’idea ardita della pubblicazione dell’Opera Omnia di sant’Agostino in edizione
bilingue latino-italiana, che oggi comprende 68 volumi con introduzioni che costituiscono
autentici studi monografici. La pubblicazione fu affidata all’Editrice Città
Nuova. In occasione di un incontro con uno dei responsabili dell’editrice, Carmelo
Failla, p. Trapé gli espresse il proprio pensiero su Chiara Lubich e il Movimento
dei Focolari, rilevando «la specialissima sintonia che scopriva lì [negli
scritti di Lubich] con la spiritualità di Agostino». Fino ad esclamare:
«Diteglielo alla signorina Chiara Lubich: ditele che è proprio agostiniana:
nel senso che tutti i temi che sono centrali in Agostino, sono centrali anche
qui in questi scritti. E senza che lei, certamente, abbia studiato
sant’Agostino: il che è segno di un’esperienza spirituale autentica».
Negli scritti di Chiara lo avevano colpito tre punti in particolare: «il
riferimento – tanto caro ad Agostino – alla vita della prima comunità
cristiana; l’altro: la carità, così centrale qui come in sant’Agostino; e poi:
“Dio – tutto della vita”, così stagliato e dominante».
Informata di questo apprezzamento di p. Trapé, Chiara Lubich
le scrisse il giorno seguente, 22 settembre 1965: «Dunque: il Generale degli
agostiniani mi dice… agostiniana! Qualcosa ci deve essere di vero! Grazie,
Padre, non naturalmente per me, ma per la spiritualità che ispira la nostra
Opera. Grazie a nome dell’Opera, dunque, che d’ora in poi avrà un nuovo (anche
se sempre amatissimo) protettore in sant’Agostino».
Il primo incontro di Lubich con Agostino risale forse agli
studi delle Scuole Magistrali, quando, alla ricerca della verità, rimane
colpita dall’agostiniano “In interiore homine habitat veritas”, la verità abita
nell’intimo dell’uomo, frase che torna con regolarità nei suoi scritti e
conversazioni. Ne abbiamo un’eco in una lettera del 1943: «Rientra in te: cerca
Dio, il tuo Dio, quello che vive in te! Se tu conoscessi chi porti in te! Se tu
tutto lasciassi per lui...», che termina con il riferimento esplicito a Le
Confessioni: «Che la vostra giovinezza non scappi e fra i singhiozzi di una
vita fallita, non vi tocchi dire con sant’Agostino: “Tardi ti ho amato! Tardi
ti ho amato, bellezza sempre antica e sempre nuova!”. No! (...) Ora ti amo, mio
Dio, mio Tutto!». Le prime focolarine guardavano con ammirazione al gruppo che
sant’Agostino componeva con i suoi discepoli, al punto da affermare: «Eravamo
dunque all’unisono con sant’Agostino».
Dalla consapevolezza del “Dio dentro” scaturisce il ripetuto
invito ad “ascoltare quella voce”, la voce dallo Spirito Santo, la Parola del
Verbo che risuona nell’intimo e che si amplifica vivendo nell’amore: «Questa
carità – scrive l’8 aprile 1986 – ampliava, inoltre, dentro di noi quella che
chiamavamo “la voce”. La Parola vissuta la potenziava come un altoparlante,
cosicché la si distingueva bene pur fra i mille frastuoni del mondo».
Nei suoi scritti tornano inoltre le più famose frasi di
Agostino, quali: «Il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in Te»: «Signore, che io conosca me, che io conosca
Te».
Nel 1965 inizia la lettura del commento di Giovanni di sant’Agostino
appena pubblicato dall’editrice Città Nuova: «A me piace tanto, tanto. (…) Che
dono queste prediche di Agostino! Che colosso questo santo! Poche cose hanno
portato alla mia anima tanta soprannaturale felicità». A mano a mano che
prosegue la lettura esprime spesso la sua meraviglia e la sua gioia: «Sant’Agostino
è maestoso nel commentare questo passo, più che maestoso».
Nel 1970 riprende il commento al cap. 17 di Giovanni (omelie
104-111). Iniziata il 29 giugno 1970, la lettura l’accompagnerà fino al 22
luglio. Prima legge il brano del Vangelo, poi lo medita e infine legge il
commento di Agostino. Con sorpresa e gioia trova sempre una consonanza tra
quanto lei ha compreso e quanto dice il Padre della Chiesa, anche se questi
continua a suggerirle nuovi approfondimenti: «Siamo dunque all’unisono con
Agostino».
Quando il 14 luglio giunge al versetto 21, non avverte più
la sintonia con il commento di Agostino. «Questo perdere lungo la strada
l’amicizia con Agostino, proprio in ciò che più mi stava a cuore, mi ha
addolorata. Ero troppo illusa che questo reale colosso – e tale sempre lo vedo
perché tale è – fosse quasi infallibile in ogni sua interpretazione». Le strade
si dividono perché Agostino legge il Vangelo nel contesto nel quale egli vive:
davanti all’eresia occorre affermare la divinità del Verbo e la sua uguaglianza
con il Padre, Chiara invece lo legge a partire dal suo carisma, l’unità.
Nelle sue
conversazioni sulla spiritualità cita sovente Agostino: la sua dottrina
sull’Eucaristia, la volontà di Dio, l’ecclesiologia… La profonda sintonia
rimane comunque sui temi della carità e dell’unità. «E soprattutto – leggiamo
in una sua conversazione - pensiamo a sant’Agostino, per il quale l’amore
reciproco e l’unità avevano il supremo valore. È a lui che noi ci sentiamo,
infatti, particolarmente vicini». Cita volentieri l’inizio della Regola: «Il
motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella
casa e abbiate unità di mente e di cuore protesi verso Dio».
Accoglie poi la
descrizione che Agostino dà della Chiesa confrontandola con quanto si vive
nella Mariapoli: «Di essa, splendido fiore della Chiesa – nato sul e per e nel
comandamento nuovo di Gesù –, ci sembrava di poter ripetere quanto Agostino
diceva della Chiesa: “Ciò che Babele disperse / la Chiesa raccoglie; /da una
lingua ne vennero tante; / non ti meravigliare: / questo l’ha fatto la
superbia. / Molte lingue diventano una; / non ti meravigliare: / questo lo fa
l’amore”».
La Chiesa, sin dalla
sua fondazione, era carità, era comunione – Agostino dice che essa consiste
nella «comunione di tutto l’orbe». «Mi è parso di capire che alla nostra Opera
si poteva dare un nome, il nome che Agostino dava spesso alla sua Chiesa: Carità».
Pensando alla vita di comunione tra le persone con le quali
viveva in focolare, trovava un altro elemento di sintonia con l’amicizia
agostiniana, ed amava citare Le Confessioni: «I colloqui, le risa in compagnia, lo scambio di cortesie
affettuose, le comuni letture, i libri ameni, i comuni passatempi ora frivoli
ora decorosi, i dissensi occasionali, senza rancore, come di ogni uomo con se
medesimo, e i più frequenti consensi, insaporiti dai medesimi, rarissimi
dissensi; l’essere ognuno dell’altro ora maestro, ora discepolo, la nostalgia
impaziente di chi è lontano, le accoglienze festose di chi ritorna. Queste e
simili segni di cuori innamorati l’uno dell’altro, espressi dalla bocca, dalla
lingua, dagli occhi e da mille gesti gradevolissimi, sono l’esca, direi, della
fiamma che fonde insieme le anime e di molte ne fa una sola».
La profonda unità teologale sapeva unire l’aspetto
altrettanto profondo dell’amicizia umana in tutta la sua concretezza.
Agostino può continuare ancora a ispirare.

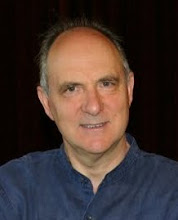
Nessun commento:
Posta un commento