 Mai visto la “Madonna della catena”? È una
stupenda tavola del 1200 riproducente la Virgo lactans (la bizantina Galaktotrophousa),
la Madonna che allatta Gesù Bambino. Ha preso questo nome perché si racconta che tra il 1646 e il 1650 un giovane
uscito di senno, tenuto in ceppi per due anni, fu miracolosamente guarito dalla
sacra immagine, presso la quale lasciò come ex voto la catena che lo aveva
avvinto. Vale la pena entrare nella chiesa di san Silvestro al Quirinale anche
solo per contemplare questo capolavoro.
Mai visto la “Madonna della catena”? È una
stupenda tavola del 1200 riproducente la Virgo lactans (la bizantina Galaktotrophousa),
la Madonna che allatta Gesù Bambino. Ha preso questo nome perché si racconta che tra il 1646 e il 1650 un giovane
uscito di senno, tenuto in ceppi per due anni, fu miracolosamente guarito dalla
sacra immagine, presso la quale lasciò come ex voto la catena che lo aveva
avvinto. Vale la pena entrare nella chiesa di san Silvestro al Quirinale anche
solo per contemplare questo capolavoro.
La chiesa rimane fuori del giro turistico e
apparentemente è inaccessibile. Si trova sulla strada che da Piazza Venezia porta
al Quirinale. Una chiesa piuttosto bizzarra, con una bella facciata… ma puramente
ornamentale, senza porta d’entrata. La cosa è dovuta al fatto che nel 1877,
quando il Quirinale, che fino alla conquista di Roma da parte dei Piemontesi
era stato la sede del papa, divenne la reggia del re d’Italia, la strada che
passava davanti alla chiesa fu allargata e abbassata, tagliando la parte
frontale: la facciata e le prime due cappelle laterali. La chiesa è rimasta
così “per aria”, nove metri più in alto rispetto al livello stradale. Per
entrare occorre suonare alla casa dei Padri della Missione, salire le scale,
entrare nel loro appartamento, e da lì in chiesa.
Fu il punto di approdo di sant’Eugenio quando
venne a Roma la prima volta, nel 1825, per chiedere al papa l’approvazione
della sua Regola. Aveva scelto di abitare con i Padri della Missione per essere
più vicino alla casa del papa, il Quirinale, appunto, in maniera da sbrigare
più facilmente le sue pratiche. «Alloggio a S. Silvestro, presso il palazzo del
Quirinale – scrive appena arrivato il 26 novembre 1925, appena arrivato a Roma
–. È il noviziato e lo studentato dei missionari di S. Vincenzo de' Paoli». Era
contento di avere insieme «l'altare e la mensa», e anche di trovarsi proprio in
mezzo ai figli di quel san Vincenzo de’ Paolo, che amava in un modo tutto
particolare: era uno dei santi che lo avevano ispirato nella fondazione dei
Missionari di Provenza.
Nella prima lettera scritta al futuro primo
compagno, p. Tempier, era già nominato come un santo da imitare: «Vivremo
assieme in una casa da me comprata sotto una Regola che adotteremo di comune
intesa, ispirandoci agli statuti di S. Ignazio, di S. Carlo, di S. Filippo
Neri, di S. Vincenzo de’ Paoli e del
b. Alfonso dei Liguori» (9 ottobre 1815). Due anni più tardi, scrivendo alla
comunità da Parigi, dopo la data, 19 luglio 1817, aggiunge: «Festa del nostro
santo patrono S. Vincenzo de’ Paoli» (fino al 1969 la celebrazione liturgica
era in quel giorno). In seminario aveva scelto un santo al giorno, durante la settimana, da
invocare come patrono: a san Vincenzo era dedicato il martedì. Finalmente ad
Amiens incontrò per la prima volta i Padri della Missione: avevano la direzione
del seminario nel quale fu accolto per la preparazione all’ordinazione sacerdotale.
Fu lì che venne attratto dallo stemma e dal motto dei Vincenziani, che poi
avrebbe fatto proprio, trasmettendolo ai Missionari di Provenza.
 Si trovò bene in questa casa e in questa chiesa di
Roma, al punto che vi ritornò altre tre volte, nei successivi viaggi. Era
edificato dai novizi che vivevano in quell’ambiente: «Vedo qui noviziati che mi
fanno invidia». Anche gli studenti di filosofia gli fecero bella impressione: «Devo
dire che questi giovanotti sono meravigliosi e mi procurano grande
edificazione; prego il Signore che ci dia il conforto di averne di simili» (6
dicembre 1825).
Si trovò bene in questa casa e in questa chiesa di
Roma, al punto che vi ritornò altre tre volte, nei successivi viaggi. Era
edificato dai novizi che vivevano in quell’ambiente: «Vedo qui noviziati che mi
fanno invidia». Anche gli studenti di filosofia gli fecero bella impressione: «Devo
dire che questi giovanotti sono meravigliosi e mi procurano grande
edificazione; prego il Signore che ci dia il conforto di averne di simili» (6
dicembre 1825).
Si trovava bene anche perché dalla sua stanza aveva
una meravigliosa vista su tutta Roma: «Sono contento del bello spettacolo che
scopro dalla mia finestra da dove spazio su tutta la città vedendo davanti a
me, sotto il giardino della casa dove abito, i giardini di Palazzo Colonna; di
fronte, a poca distanza, le cupole del Gesù e di altre chiese; un po’ più
lontano S. Andrea della Valle; a sinistra la Colonna Traiana, a poca distanza
da lì il Campidoglio, a destra S. Ignazio, il Collegio Romano e l’osservatorio;
più lontano la Colonna Antonina, Montecitorio, piazza del popolo e tanti altri
notevoli edifici; al di sopra di tutto questo bel Vaticano e questa incomparabile
cupola di S. Pietro: tutta la città insomma» (Diario, 13 dicembre 1825).
Non proprio tutto era perfetto in questa casa, per
esempio la cucina. «Nonostante ogni sforzo – scriveva all’amico p. Tempier –,
non posso mandar giù l'olio pessimo in uso a Roma. Durante le Quattro Tempora
si osserva lo stretto magro con proibizione di uova e latticini, ed io ho
ringraziato il Signore di non essermi avvicinato a quell'olio orrendo,
contentandomi a pranzo di un pezzo di pesce bollito su cui ho spremuto mezzo
limone» (18 dicembre 1825). La cosa non cambiò con il passare dei mesi. Il 16
marzo 1826 torna sull’argomento: «Terminata
la quaresima riprenderò le forze, perché vi confesso che in vita mia non ho
fatto una quaresima come questa. Mi capita spesso di passare una giornata con
in corpo due uova cotte male, e per giunta è vietato mangiarne più di tre volte
alla settimana. Provo una ripugnanza invincibile a inghiottire l'olio pestifero
usato in casa: quando mi passano il pesce lo butto giù senza condimento, ma
qualche volta non scende; anziché inghiottire vomiterei i tre pezzetti di
un'altra specie di pesce che hanno macerato nell'aceto insieme a erbe
aromatiche, qualcosa che rivolta lo stomaco. Di frequente la minestra è
disgustosa al massimo: è un miscuglio di formaggio pane ed erbe; la caccio in
gola per forza, poi mi rifaccio con la frutta, mangio pane e noci, mandorle e
di solito due pere che non rifiuto mai».
In compenso la conversazione
con i religiosi della casa lo edificava: «Ho fatto la ricreazione con p. Collucci, uno dei nostri Lazzaristi, di 74
anni. Gliene avrei dato sessanta. Non posso esprimere quanto sia stato
edificato dalla sua bella semplicità, dalla bellezza della sua anima e dai
sentimenti che esprimeva con ammirevole dolcezza. (…) Mi diceva che (…) tutti i
giorni ringraziava Dio della sua vocazione. Avevo già notato la carità con cui,
tutti i giorni, era pronto ad andare al confessionale e i suoi modi rispettosi
verso tutti. Credo che questo prete sia un grande servitore di Dio. Mi diceva
anche che ciò che più contribuiva alla sua felicità era ricevere tutto dalle
mani di Dio» (6 dicembre 1825).
 Si trovò subito a casa anche perché, con sua
sorpresa, scoprì che nella chiesa si conservava la tomba del suo maestro Bartolo Zinelli, al tempo
dell’esilio a Venezia. Così scrive a Courtès il 6 dicembre 1825: «Non vi ho pure ritrovato il ricordo, il busto e il
corpo stesso sepolto in chiesa di quel santo sacerdote, di cui hai sentito
parlare così spesso, il grande servo di Dio Bartolomeo Zinelli che fu mio
maestro a Venezia ed è morto in odore di santità sotto questo tetto? La sua
causa di beatificazione sarebbe già iniziata da gran tempo se la Società di cui
era membro non fosse stata disciolta (…).Lui non aveva che virtù, e il Vescovo
del luogo dove diede l'ultima missione volle che si stilasse l'atto autentico
di una profezia fatta nella sua diocesi e verificatasi a puntino. (…) È per me
una consolazione respirare la medesima aria, offrire il santo sacrificio sugli
stessi altari, pregare sulla sua tomba». La tomba non c’è più, sparita con la
demolizione di parte della chiesa in seguito all’ampiamento della strada.
Si trovò subito a casa anche perché, con sua
sorpresa, scoprì che nella chiesa si conservava la tomba del suo maestro Bartolo Zinelli, al tempo
dell’esilio a Venezia. Così scrive a Courtès il 6 dicembre 1825: «Non vi ho pure ritrovato il ricordo, il busto e il
corpo stesso sepolto in chiesa di quel santo sacerdote, di cui hai sentito
parlare così spesso, il grande servo di Dio Bartolomeo Zinelli che fu mio
maestro a Venezia ed è morto in odore di santità sotto questo tetto? La sua
causa di beatificazione sarebbe già iniziata da gran tempo se la Società di cui
era membro non fosse stata disciolta (…).Lui non aveva che virtù, e il Vescovo
del luogo dove diede l'ultima missione volle che si stilasse l'atto autentico
di una profezia fatta nella sua diocesi e verificatasi a puntino. (…) È per me
una consolazione respirare la medesima aria, offrire il santo sacrificio sugli
stessi altari, pregare sulla sua tomba». La tomba non c’è più, sparita con la
demolizione di parte della chiesa in seguito all’ampiamento della strada.
Si sentiva a casa sua anche perché nella chiesa c’è
una cappella nella quale è affrescata la sua Provenza. Attualmente è l’ultima a
destra. Vi sono raffigurate la vita contemplativa e quella attiva,
rappresentate rispettivamente da Maria Maddalena e Caterina da Siena.
Secondo la tradizione
Maria Maddalena, assieme al fratello Lazzaro e alla sorella Marta, dopo aver
lasciato la loro terra per sfuggire alla persecuzione, trovarono rifugio nella
Provenza. A San Massimino, vicino ad Aix, sulla grotta dove Maria Maddalena era
rimasta in penitenza per trent’anni, nel XIII secolo fu innalzata, su
precedenti luoghi di culto, una grande basilica, oggetto di pellegrinaggi
continuati fino alla Rivoluzione francese, quando il culto venne meno.
Sant’Eugenio si adoperò molto perché esso tornasse in auge. L’affresco mostra
Maria Maddalena immersa in un meraviglioso scenario provenzale.
Santa Caterina da Siena è
raffigura ad Avignone, nella città dei papi vicini ad Aix, mentre dialogo con
il papa per riportarlo a Roma: ancora una volta l’affresco descrive luoghi cari
ad Eugenio.
San Silvestro al Quirinale: la casa e la chiesa
romana di sant’Eugenio. Se sommiamo tutti i suoi soggiorni, vi ha dimorato per
più di un anno. Vale la pena salire alla chiesa: buona visita, in compagnia di
sant’Eugenio.



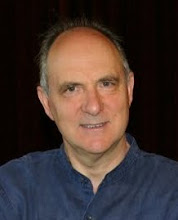
Nessun commento:
Posta un commento