 |
| Convento delle Celle a Cortona |
Era nato il 21 ottobre 1883, nell’attuale territorio della parrocchia di S. Paolo,
presso Prato. I suoi genitori, Pietro Ciardi ed Assunta Carlesi, al battesimo
gli imposero il nome di Tommaso. Era una famiglia piuttosto agiata di
contadini, con case e terreni a S. Paolo e a Galciana. Una famiglia
profondamente cristiana, che tra l’altro contribuì notevolmente alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale. Tommaso, ultimo di cinque figli, fu affidato ad una balia di Sasseta. seconde un
costume allora comune tra le famiglie di un certo tenore.
Quando a 19 anni, il 5 marzo 1902, vestì l’abito religioso, la sorella
Amelia era già entrata nel convento delle Agostiniane a Radicondoli, col nome di Suor Luisa. L’8
marzo 1903 emise la Professione semplice, ed il 4 ottobre del 1907, festa di S.
Francesco, quella solenne. Il 19 luglio 1912 fu ordinato sacerdote. Avrebbe desiderato
partire in missione in India, come il suo coetaneo Fr. Ludovico Tassi di Galciana, ma i superiori non ve lo
mandarono mai, forse perché di costituzione piuttosto gracile. Lo mandarono
invece nella sua Prato, dove rimase per due anni, fino a quando nel 1915 fu
destinato a S. Maria Nuova. Ma presto dovette lasciare l’ospedale per vestire
la divisa militare e partecipare alla grande guerra.
“Sotto le armi -- scrive ancora Fr. Luigi - si
mantenne fedele alla Vocazione religiosa,
facendo onore al suo sacerdozio, con una vita illibata”. Anche qui il sospetto che si tratti di una annotazione di circostanza
svanisce se teniamo conto che una quarantina di cappuccini della Provincia toscana, i più giovani
specialmente, terminata la guerra non fecero più ritorno nei conventi (Cfr. Epifanio da s. Marcello, Durante la Grande Guerra, in Memoriale, o.c., p. 331-343). “Chi dei nostri è
sotto le armi - aveva raccomandato il Padre Provinciale al momento della mobilitazione generale - adempia
non per timore ma per coscienza tutto il dovere, e sia modello agli altri di
disciplina, di coraggio, di valore, di
virtù. Tenga fermo che se Dio permette il Religioso o il Prete Soldato,
lo permette perché eserciti una Missione divina là dove maggiore è il bisogno.
Compiano pertanto i Nostri questo apostolato fecondo di aiuto, di
rassegnazione, di pace, di salvezza delle anime. Ne avranno gran Merito dinanzi
a Dio, ed onoreranno la Madre Provincia, che li benedì partenti, che prega per la loro incolumità,
che affretta col desiderio la gioia del loro felice ritorno” (Ignazio da Seggiano, Lettera circolare ai PP. Cappuccini di Toscana, Firenze,
2 giugno 1915). P. Evangelista ha certamente risposto all’appello
del suo Provinciale, come appunto ci testimonia il P. Luigi.
 Alla fine della guerra poté fare ritorno a S. Maria Nuova dove fino al
1927 ebbe cura dei malati “con carità veramente singolare” (Luigi da Firenze, o.c.). Nel 1927, contro
ogni sua aspettativa e desiderio, i superiori lo destinarono Presidente al
convento di Poppi, ma, dopo soli due anni, fu ancora a S. Maria Nuova, anche
qui Presidente, fino al 1932. “È un fatto - scrive P. Lorenzo da Castel del
Piano in quegli stessi anni - che la metà di Firenze e dei dintorni passa per
lo Spedale, avvicina i nostri Padri e ne riporta ottima impressione. Non si
spiega altrimenti la popolarità dei Cappuccini a Firenze e la chiamata di essi
in tutti gli altri luoghi di dolore della città. Ivi le anime si aprono
facilmente ai Religiosi, che vedono per la prima volta e sanno esser modesti e
non impolverati di mondo” (Lorenzo da Castel Del Piano, Nei tempi e nei luoghi di pena e di dolore, in Memoriale, o.c.,
p. 383).
Alla fine della guerra poté fare ritorno a S. Maria Nuova dove fino al
1927 ebbe cura dei malati “con carità veramente singolare” (Luigi da Firenze, o.c.). Nel 1927, contro
ogni sua aspettativa e desiderio, i superiori lo destinarono Presidente al
convento di Poppi, ma, dopo soli due anni, fu ancora a S. Maria Nuova, anche
qui Presidente, fino al 1932. “È un fatto - scrive P. Lorenzo da Castel del
Piano in quegli stessi anni - che la metà di Firenze e dei dintorni passa per
lo Spedale, avvicina i nostri Padri e ne riporta ottima impressione. Non si
spiega altrimenti la popolarità dei Cappuccini a Firenze e la chiamata di essi
in tutti gli altri luoghi di dolore della città. Ivi le anime si aprono
facilmente ai Religiosi, che vedono per la prima volta e sanno esser modesti e
non impolverati di mondo” (Lorenzo da Castel Del Piano, Nei tempi e nei luoghi di pena e di dolore, in Memoriale, o.c.,
p. 383).
Dopo il 1932 fu Superiore a Lucignano, Cortona, Montepulciano, Monte Casale;
nel triennio 1938-41 fu Vicario a Poppi e successivamente a Borgo S. Lorenzo.
È forse in questi anni, che seguirono la lunga
permanenza a S. Maria Nuova, che cominciarono a chiamarlo “Saltacancelli”, un
soprannome che sembrerebbe contraddire il suo modo di fare riservato e austero,
e che invece si sposa bene con “frate all’antica” e ce ne rivela nuove
sfaccettature. Saltacancelli perché camminava sempre a piedi per i campi e per
i sentieri di montagna, con fango e neve, nel vento e nella pioggia, le mani
nelle tasche dell’abito tagliate verticalmente sul petto, mormorando le sue
semplici preghiere, senza lasciarsi sbarrare il passo né da staccionate né da
siepi. Un soprannome, datogli probabilmente dai ragazzi del
“Seminario serafico” di Poppi (in quegli anni ce n’era una novantina) o dai
novizi de “La Maddalena” a Montepulciano o de “Le Celle” a Cortona, che indica come il “frate all’antica” sapesse
farsi benvolere e la sciarsi prendere un po’ in giro benevolmente.
I ragazzi e i novizi di allora, oggi frati, raccontano
mille aneddoti. Ricordano con affetto Saltacancelli che durante la seconda
guerra mondiale, in quei tempi di fame, si fa in quattro per provvedere i viveri alla comunità numerosa e lui, in
un cantuccio, si accontenta di mangiare le bucce delle mele. Lo ricordano sul
tetto ad aggiustare le tegole o dedito ai mille piccoli servizi di convento. Fa
il panettiere e va per
le campagne e nei paesi a fare la questua, in aiuto al frate cercatore.
Aneddoti e ricordi convergono tutti a dipingere il ritratto di un uomo di
penitenza, di silenzio, di preghiera, di stretta osservanza, un uomo che, pur
essendo stato a lungo superiore, si è lasciato ispirare non dai senso del
comando ma da quello del servizio, fedele al dettato della Regola francescana: “E nessuno sia chiamato priore, ma tutti siano
chiamati semplicemente frati minori. E l’uno lavi i piedi all’altro” (Regola non bollata, VI). (continua)


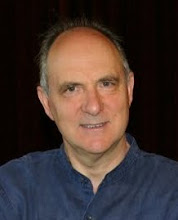
Nessun commento:
Posta un commento