Con sorpresa e meraviglia leggo sull’ultimo
volume di “Claretianum” l’inaspettata recensione del mio libro “I detti di apa
Pafnunzio”. Il Professore Maurizio Bevilacqua, a cui va tutta la mia
gratitudine, ha proposto una lettura del libro che denota una comprensione del
tutto appropriata di apa Pafnunzio.
 Apa Pafnunzio ed altri
sei anacoreti vivono in un deserto che non è dato localizzare, in un tempo
impossibile da precisare. A questo immaginario Padre del deserto Fabio Ciardi
affida la propria riflessione sulla vita consacrata - non solo quella eremitica
- e, più in generale, sulla vita e sulla fede.
Apa Pafnunzio ed altri
sei anacoreti vivono in un deserto che non è dato localizzare, in un tempo
impossibile da precisare. A questo immaginario Padre del deserto Fabio Ciardi
affida la propria riflessione sulla vita consacrata - non solo quella eremitica
- e, più in generale, sulla vita e sulla fede.
Come il grande Antonio e
tanti altri nel corso della storia, Pafnunzio è condotto nel deserto dalla voce
misteriosa, ma realissima, di Gesù avvertita nella proclamazione del Vangelo.
Il deserto è luogo privilegiato per l'ascesi, per far morire l'uomo vecchio e
far sorgere il nuovo, e l'eremita ne ama la sconfinata solitudine e il silenzio
profondo.
L’Autore presenta il
cammino percorso dall'anacoreta centrato sulla gloria da riconoscere a Dio:
gloria al Padre (pp. 80-32) e al Figlio (pp. 109-110) e allo Spirito Santo
(pp.123-124). Tale cammino si chiarisce progressivamente, lasciando cadere la
pretesa di fare qualcosa per Dio, addirittura di stupirlo, per giungere ad
offrire a Dio la propria povertà e lasciare che agisca Lui. È così che, in un
racconto di Pafnunzio ai suoi compagni, il quarto Magio, attardatosi nei propri
peccati e giunto a Gerusalemme solo in tempo per vedere Gesù confitto alla
croce, si sente dire da Questi che proprio il dono dei suoi peccati era quello
che aveva atteso per una vita: «Ora sai perché sono venuto sulla terra» (p. 112).
Come buon anacoreta, Pafnunzio aspira alla santità ed è convinto che in ogni
situazione è possibile raggiungerla; con il trascorrere del tempo, però, giunge
a comprendere «che la santità non si conquista, ma la si accoglie come un dono»
(p. 118).
I lunghi anni nel deserto
insegnano ad assumere le debolezze e i fallimenti e a riconoscere la
misericordia di Dio: «Ormai apa Pafnunzio lo sapeva: non si sarebbe mai
salvato, ne era incapace. La perfezione consisteva nell'essere salvato. "Tu
inizi - disse apa Pafnunzio - dove io m'arresto"» (p. 129).
 Un altro pensiero
attraversa la mente del nostro eremita; egli si chiede a chi giovi la sua vita
di «solitario ignoto, nascosto in una grotta lontana, in un deserto lontano»
(p. 135). La domanda che Fabio Ciardi mette sulle sue labbra non riguarda,
però, solo il significato della vita erémitica. L’inquietudine di Pafnunzio
circa il senso della sua esistenza, nota solo ai pochi compagni della laura nel
deserto e a qualche carovaniere di passaggio, non è molto dissimile da quella di
tanti di noi circa una quotidianità monotona spesa in una piccola cerchia di
conoscenze - fosse pure nel deserto di una grande città - con la certezza che
non si compiranno mai gesta memorabili e che la nostra esistenza sarà ignorata
dal mondo. È nella comunione dei santi che l'Autore fa trovare una risposta al
suo immaginario apa, partendo proprio dalla tradizione monastica. Come
insegnava Basilio, «nessuno basta a ricevere tutti i carismi spirituali e,
nella vita comunitaria, il carisma proprio di ciascuno diviene comune a tutti
quelli che vivono con lui» (Regulae
fusius tractatae, interrogatio VII, in PG 31,932). Questo, nella redenzione
in Cristo, si estende all'intera comunità dei figli di Dio. Il monaco, perciò,
è colui che «separato da tutti è a tutti unito», secondo il detto di Evagrio
Pontico (De oratione, 124, in PG 79,
1193).
Un altro pensiero
attraversa la mente del nostro eremita; egli si chiede a chi giovi la sua vita
di «solitario ignoto, nascosto in una grotta lontana, in un deserto lontano»
(p. 135). La domanda che Fabio Ciardi mette sulle sue labbra non riguarda,
però, solo il significato della vita erémitica. L’inquietudine di Pafnunzio
circa il senso della sua esistenza, nota solo ai pochi compagni della laura nel
deserto e a qualche carovaniere di passaggio, non è molto dissimile da quella di
tanti di noi circa una quotidianità monotona spesa in una piccola cerchia di
conoscenze - fosse pure nel deserto di una grande città - con la certezza che
non si compiranno mai gesta memorabili e che la nostra esistenza sarà ignorata
dal mondo. È nella comunione dei santi che l'Autore fa trovare una risposta al
suo immaginario apa, partendo proprio dalla tradizione monastica. Come
insegnava Basilio, «nessuno basta a ricevere tutti i carismi spirituali e,
nella vita comunitaria, il carisma proprio di ciascuno diviene comune a tutti
quelli che vivono con lui» (Regulae
fusius tractatae, interrogatio VII, in PG 31,932). Questo, nella redenzione
in Cristo, si estende all'intera comunità dei figli di Dio. Il monaco, perciò,
è colui che «separato da tutti è a tutti unito», secondo il detto di Evagrio
Pontico (De oratione, 124, in PG 79,
1193).
È con questa prospettiva
che si può affrontare anche l'ultima e la più grande della inquietudini della vita.
La morte può essere un pensiero lontano; una realtà incombente, ma non
imminente: «Perché, invece di attendere la morte, ... non vivere come se
l'incontro avvenisse adesso?» (p. 26). È diverso, però, quando essa si profila
innanzi come passaggio certo ed ormai prossimo: «"Matanathà, vieni Signore
Gesù" ... Pregava con ardore, ma nello stesso tempo aveva timore di quel
ritorno o, più semplicemente, aveva paura di morire» (p. 111). È raccogliendo
la vita, con le piccole relazioni che ha costruito, e ponendo tutto innanzi al
suo Signore che Pafnunzio supera la paura. La sua morte sarà lo specchio del
cammino compiuto: «Da giorni gli stavano attorno, vegliandolo amorevolmente, fratelli
veri come sempre lo erano stati. A loro, con volto disteso, irradiando luce e
pace, apa Pafnunzio rivolse le sue ultime parole» (p. 138).
Auguriamo al lettore che
il viaggio di Pafnunzio lo possa aiutare ad attraversare i propri deserti.
Questa mattina, durante la lezione di storia della
vita consacrata, ho letto una pagina dei Detti a una ottantina di novizi e
novizie dei Castelli Romani. Anche loro ne sono rimasti incantati.
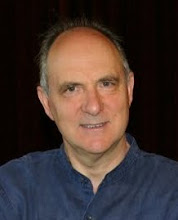
Nessun commento:
Posta un commento